Durante l’ultima grande glaciazione del Quaternario, conclusasi circa 12.000 anni fa, le foreste appenniniche si erano ritirate in località meno elevate e ben esposte rispetto alla diffusione attuale. Allora i boschi erano costituiti da faggi (Fagus sylvatica), querce (Quercus cerris, Quercus petrea), betulle (Betula pendula), abeti, pecci (Picea abies), pini neri (Pinus nigra) e mughi (Pinus mugo). Il clima freddo, ma soprattutto la minore durata della stagione calda, aveva favorito non poco la diffusione delle conifere, anche se la loro partecipazione alle cenosi forestali non era quantitativamente ai livelli che queste hanno oggi sulle Alpi. Il faggio e le latifoglie anche allora avevano un comportamento molto competitivo sull’Appennino, favoriti dalla litologia di queste montagne, generalmente calcaree e quindi generanti suoli più fertili di quelli alpini. Durante le fasi aride prevalevano boschi di abete bianco, pino mugo, pino silvestre (Pinus sylvestris) e querce, mentre nelle fasi più umide il faggio dominava sulle conifere. Al termine della glaciazione, la riconquista e la risalita delle foreste è stata rapida e decisa. Già dopo pochi millenni, la faggeta aveva rimpiazzato quasi totalmente i pini, relegandoli nelle zone meno fertili e rocciose in genere, mentre l’abete, il tasso (Taxus baccata) e l’agrifoglio (Ilex aquifolium), erano ancora vistosamente presenti all’interno delle cenosi forestali del postglaciale.
Oggigiorno le foreste montane appenniniche sono edificate soprattutto dal faggio, che regna incontrastato laddove l’uomo gli ha permesso di sopravvivere. Infatti, è piuttosto comune osservare interi versanti spogli, privi di alberi, testimoni di una lunga tradizione pastorale, che vedeva nel bosco un impedimento alla diffusione di tale forma di economia. In genere l’eliminazione dei boschi è avvenuta sui versanti meridionali dei monti, dove più facile è il pascolo, che sull’Appennino prosegue anche durante la stagione invernale. Tuttavia, anche i freschi versanti settentrionali non sono stati risparmiati del tutto perché la forte richiesta di legna, dapprima da opera e poi da ardere, ha prodotto inevitabili conseguenze anche sulla consistenza di queste faggete. Le prime forme di sfruttamento forestale, volte a produrre legname da opera, hanno interessato prima le conifere che erano riuscite a competere con l’invadente faggio, abete bianco in primis, dotato di ottimo legname, un tempo molto richiesto dall’industria navale e dall’edilizia. Lo sfruttamento dell’abete è proseguito per millenni, portando la specie ad un rapido collasso. In realtà le sorti dell’abete bianco appenninico sarebbero state ugualmente nefaste perché la sopravvivenza di questa bella conifera è legata indissolubilmente alla conservazione delle faggete ad uno stato primitivo ed originario. Difatti, nel postglaciale l’abete aveva assorbito “l’onda d’urto” provocata dall’avanzata del faggio approfittando del fatto che la faggeta tende a costituire boschi coetanei nelle regioni più fertili e meno elevate, che si rinnovano in massa poco prima del crollo delle piante vecchie, mentre l’abete presenta rinnovazione continua anche sotto la copertura di altri alberi.
Questo diverso comportamento aveva permesso all’abete di mantenere una posizione subordinata ma costante perché la conifera riusciva a riprodursi prima del faggio e questo gli permetteva di avere un vantaggio iniziale sulla latifoglia, che però poi si riduceva quando il faggio si rinnovava in massa, saturando tutti gli spazi a disposizione. Questo meccanismo è andato avanti per millenni, fino a quando l’uomo non ha iniziato a tagliare le faggete, rompendo il delicato equilibrio creatosi in precedenza. Venendo a mancare la fase di crollo delle faggete, l’abete,indipendentemente dai forti prelievi di cui è stato oggetto, non ha più avuto la possibilità di mantenere le posizioni e la sua presenza è andata sempre più rarefacendosi. L’introduzione di una regolamentazione delle utilizzazioni forestali non ha portato alcun giovamento al mantenimento del consorzio misto faggio abete poiché, prima con il taglio raso con riserve della Legge Forestale del 1826 (Legge Borbonica) e poi con il taglio successivo, viene comunque a mancare una simulazione della fase di crollo della faggeta perché manca la fase cronologica del soprassuolo cadente, che può durare anche un secolo, essenziale per la rinnovazione dell’abete. Un esempio recente dell’impatto che hanno le utilizzazioni sul delicato equilibrio faggio/abete lo abbiamo avuto nella foresta del Gariglione, in Sila Piccola. La prima utilizzazione industriale di questo bosco è iniziata nel 1929 ed è durata, tra fasi alterne, circa 25 anni. Il bosco venne utilizzato mediante l’applicazione del taglio raso con riserve. Vennero tagliate tutte le piante, indistintamente dalla specie, aventi diametro a 1,30m > 20cm. Interessante il confronto con la percentuale di faggio e abete prima dei tagli e quella successiva. Prima dei tagli, la proporzione dell’abete rispetto al faggio era del 17%, mentre successivamente alle utilizzazioni questa era salita fino al 42%, con una media del 29% (Carullo, 1952). A prima vista sembra che vi fosse stato un netto miglioramento rispetto alle condizioni precedenti, tale da giustificare l’intervento stesso. Tuttavia, se analizziamo un altro dato, ovvero quello della variazione della massa dendrometrica, ci accorgiamo che il bosco era state letteralmente devastato dalle utilizzazioni. Infatti, la provvigione media era passata dagli ottimi 1079 mc/ha ai miseri 176mc/ha. In pratica, in un unico intervento, era stato asportato circa l’84% della massa legnosa, rappresentata spesso da piante monumentali o di dimensioni ragguardevoli. Dai rilievi dendrometrici effettuati prima dell’inizio dei tagli si evince la presenza di veri e proprio monumenti vegetali: nel bosco erano diffusi abeti di 250 cm di diametro per 44 m di altezza, con volumi fino a 41mc. Fortunatamente, la diffusa ed incipiente rinnovazione presente sotto la copertura delle piante vecchie e “stramature” permise al bosco di rinnovarsi velocemente e senza difficoltà, ma l’apparente aumento in percentuale dell’abete non si tradusse in una vera ripresa della specie poiché, venuta a mancare la protezione delle piante adulte, spesso la rinnovazione deperiva velocemente, soprattutto quella di abete. In altri casi, il taglio degli abeti monumentali lasciava vuoti enormi, prontamente invasi dal pino laricio oppure dal salicone. Molte oasi di pino larico e salicone ancora presenti all’interno del bosco, soprattutto nel versante del Tacina, sono proprio la conseguenza di questi interventi, perpetrati senza ragione alcuna se non quella di aumentare i già lauti guadagni della SO.FO.ME….. Oggigiorno, la situazione del Gariglione non è sostanzialmente cambiata da quella del 1923 poiché le sorti dell’abete, nonostante la struttura nettamente diversa da quella di allora, non sono idonee alla conservazione della conifera. La massa dendrometrica (volume del bosco) è notevolmente cresciuta, arrivando a raggiungere persino i 1300mc/ha nelle zone più fertili e meno degradate dalla SO.FO.ME.. La coetaneità generalizzata del soprassuolo, associata ad una età relativamente modesta, nonostante la diffusa presenza di rinnovazione d’abete sotto copertura, non depone a favore di un aumento della participazione al consorzio misto. Semmai, nel medio/lungo periodo (50-100 anni), ipotizzando una totale cessazione delle utilizzazioni, è già evidente come il faggio tenderà a sopraffare pressoché dovunque l’abete, avvalendosi della copertura uniforme ed intensa; questa provocherà un diffuso deperimento delle decine di migliaia di abetini ora presenti, che rimarranno inutilmente in attesa di un improbabile crollo di qualche tratto di faggeta. Le uniche chance a favore dell’abete sono l’invasione delle pinete del poco concorrenziale pino laricio.
Attualmente, la presenza dell’abete in Appennino è marginale e la specie rappresenta in percentuale una frazione insignificante della copertura forestale montana appenninica. In genere, i nuclei residui di abete sono situati in posizione lontane dai centri abitati ed, a seconda dell’area geografica, collocati in aree più o meno marginali della faggeta. I limiti altitudinali dell’abete non crescono regolarmente progredendo verso meridione, ma seguono più i dettami imposti dall’utilizzo antropico del territorio.
|
APPENNINO |
Limite inferiore |
Limite superiore |
Piante isolate – |
Piante isolate + |
|
Settentrionale |
1100 |
1700 |
1000 |
1700 |
|
Centrale |
600 |
1800 |
600 |
1800 |
|
Meridionale |
600 |
1900 |
600 |
1950 |
Tabella – Estensione altitudinale dell’abete sull’Appennino
Sull’Appennino settentrionale l’abete è presente con diversi nuclei relitti, genericamente insediati ai limiti superiori o inferiori delle faggete oppure in luoghi dove la vegetazione del faggio è ridotta, ovvero in aree rocciose e/o aspre. Questa dislocazione è favorita dalla litologia argillosa di questa parte dell’Appennino, che permette una buona conservazione dell’umidità, associata ad una minore fertilità del suolo stesso. Sull’Appennino settentrionale troviamo anche alcuni nuclei di abete consociato al peccio (Picea abies) di notevole interesse biologico e fitogeografico in quanto questa presenza del peccio è l’ultimo ricordo di un ormai estinto orizzonte di conifere montane sovrapposto alle faggete, ancora largamente presente e dominante sulle Alpi. Lembi di abetine miste a peccio ed abete si incontrano nei pressi del Monte Sillara, al Lago Verde, al Monte La Nuda, ma il nucleo più rappresentativo è certamente quello presente nella Riserva di Campolino, nella Valle del Sestaione, non distante dalla località turistica de “l’Abetone”. Questo modesto, ma significativo, nucleo di abetina rappresenta il più importante relitto della citata fascia di conifere montane che sovrastava la faggeta in epoche passate e che l’uomo ha decimato ed annientato per aprire gli spazi necessari al pascolo dei suoi armenti. In questo piccolo relitto il peccio e l’abete ricostituiscono un rarissimo esempio di vegetazione alpina, con una abbondante presenza dei mirtilli nero e falso (Vaccinium myrtillus e uliginosum), del sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia) e della moretta palustre (Empetrum nigrum), quest’ultima al limite meridionale di distribuzione.
Nell’Appennino centrale la presenza dell’abete è più frammentaria e spesso i nuclei di abete distano tra loro decine di chilometri. Sui Monti della Laga, come sull’Appennino settentrionale, l’abete, grazie alla natura argillosa dei suoli, riesce a mantenere in alcune limitatissime località una posizione dominante sul faggio, ma questo accade sempre ai margini inferiori della faggeta (Cortino). Mancano del tutto le abetine sommitali poiché ovunque il limite superiore del bosco è stato ribassato dall’uomo di decine o centinaia di metri, mentre è ovunque chiara la tendenza ad un “infaggiamento” dei boschi, con conseguente arretramento di tutte le altre specie forestali concorrenti. Non è raro, infatti, trovare l’abete consociato alle latifoglie pioniere, come gli aceri (Acer pseudoplatanus e obtusatum), il frassino (Fraxinus excelsior), il tiglio (Tilia cordata) e finanche il carpino nero (Ostrya carpinifolia). Queste associazioni, spesso in precarie condizioni vegetative, soprattutto dell’abete, di solito si ritrovano sui macereti, nelle zone già adibite a coltivi e presso le aree rocciose (su argille e marne).
Nuclei di abete più estesi si trovano al confine tra Abruzzo e Molise. Si tratta di abetine che crescono nella zona di tensione tra la cerreta (Quercus cerris) e la faggeta e che in molti casi sono stati risparmiati per motivi economici (Rosello, Collemeluccio). In questi ambienti, l’abete si associa ancora al cerro, al frassino maggiore, al tasso (Taxus baccata), all’agrifoglio (Ilex aquifolium) ed agli aceri, mentre il faggio spesso rimane in posizione subordinata, denotando così il carattere submontano della formazione. Infatti, all’aumento dell’altitudine corrisponde sempre un drastico calo dell’abete. Più a sud, le tracce dell’abete sfumano decisamente. Sul Matese l’abete è in evidente estinzione. Sono rimaste solamente pochissime piante senza traccia di rinnovazione. Stessa sorte la stanno subendo gli abeti dei Monti Picentini e dei Monti Alburni dove il faggio è estremamente aggressivo e le utilizzazioni forestali, molto presenti e puntuali, non lasciano scampo alla conifera. Tracce più consistenti si trovano sui versanti argillosi del Monte Motola, sopra il Vallo di Diano, dove l’abete riesce ancora a sopravvivere nell’area di tensione tra la faggeta ed una probabile cerreta oggi non più esistente, sostituita da formazioni di nocciolo (Corylus avellana), ed acero opalo (Acer opalus Mill.). Degna di nota è la totale assenza dell’abete sui suoli calcarei, luogo d’elezione per il faggio. Altre formazioni significative di abete le ritroviamo sul grande massiccio calcareo del Pollino, dove la presenza dell’abete è concentrata sul versante orientale, area massicciamente interessata dalla presenza di argille e marne che stemperano il carattere invadente del faggio. Generalmente, l’abete si associa con il faggio, il cerro e gli aceri, ma è presente anche l’ontano napoletano (Alnus cordata (Loisel.) Duby), albero molto veloce nel colonizzare aree abbandonate ed incendiate. Sul Pollino è notevole l’escursione altitudinale dell’abete, compreso tra i 900 ed i 1900m. Infatti, si trova abete frammisto al cerro così come si rinvengono abeti associati al pino loricato (Pinus leucodermis Ant.), in chiaro ambiente di vetta.
Il Pollino è anche un ottimo campione di analisi degli effetti dell’impatto antropico sull’ecosistema bosco poiché su di esso si osservano perfettamente gli esiti delle utilizzazioni forestali coniugate ad un pascolo ovino e bovino esercitato senza alcuna regola. Nel corso dei secoli, su questo monte il pascolo è stato sempre molto presente, ma fino a quando il bosco veniva conservato ed utilizzato in modo marginale e sempre per usi locali l’equilibrio si è mantenuto stabile, fatta eccezione ovviamente per il solito abbassamento del limite superiore volto alla creazione dei pascoli estivi. Verso la fine dell’Ottocento, prima che in altri montagne appenniniche, si sono avuti massicci tagli forestali, avvenuti in un periodo di massima attività pastorale (circa 15.000 capi di bestiame presenti in zona). Una volta diradata la foresta, allora ancora in condizioni seminaturali, il pascolo si è infiltrato nelle faggeto-abetine di alta quota durante la stagione arida estiva, danneggiando i giovani alberi di faggio ed abete che stavano appena nascendo, ostacolando quindi la ripresa del bosco. Fino alla metà del Novecento, quando il sistema pastorale ebbe un forte ridimensionamento, le fasce cacuminali dei boschi del Pollino erano costituite di grandi e solitari alberi di pino loricato, faggio ed abete, mentre le pendici meno elevate erano ancora ricoperte di foreste ancora dense. In questi anni arrivò una seconda ondata di utilizzazioni forestali, questa volta eseguite con mezzi tecnologici, quali le teleferiche e le ferrovie decauveille (piccole ferrovie a scartamento ridotto), molto usate nelle utilizzazioni forestali, di cui rimangono ancora visibile le tracce in zona Serra di Crispo. Ancora una volta il pascolo entrò prepotentemente nel bosco danneggiando i giovani alberi o impedendone la crescita, ma pochi anni dopo iniziò il forte ridimensionamento degli armenti e così gran parte delle faggete riprese la crescita normale, portando con se però i segni del passato danneggiamento, mentre l’abete scomparì quasi del tutto dalle foreste più elevate.
I segni dei danni sono le grandi estensioni di pessimo bosco ceduo che si osservano attorno ai Piani del Pollino, sotto le Serre Crispo e delle Ciavole, sul Timpone Canocchiello, dove giganteschi abeti, aceri e e faggi emergono al di sopra di questi miseri boschi. Stessa sorte hanno subito anche i “colossali abeti che svettano sulla faggeta” dei monti di Orsomarso, citati dal grande botanico calabrese Biagio Longo nel 1904, ormai rimasti su questi monti con solo 3-4 esemplari malconci e con nessuna speranza di riuscire a recuperare le posizione passate. Su queste belle montagne, ammantate di estese faggete, si vedono ancora molto bene le tracce delle ferrovie che percorsero, in lungo ed in largo, tutte le valli. Per anni ed anni sui loro vagoni vennero trasportati sacchi di carbone vegetale ed i tronchi dei grandi faggi ed abeti che continuamente cadevano sotto i colpi delle accette e delle motoseghe. Sul Pollino, le ditte romane e tedesche (RUEPING) tagliarono ininterrottamente dal 1910 al 1955 e lo stesso avvenne anche nelle altre foreste lucane e calabresi. Questi intensi tagli ebbero una notevole ripercussione sulla composizione dei boschi poiché, oltre all’eliminazione diretta dell’abete, favorì non poco l’ingresso nelle cenosi forestali mature ed evolute, delle specie più frugali e pioniere. Le chiarie e le radure più grandi vennero velocemente colonizzate dall’ontano napoletano e dagli aceri i quali, ad esempio sul Monte Sparviere, appendice orientale del Pollino, sono divenuti i principali costituenti del soprassuolo esistente. Assieme agli aceri si ebbe anche una forte risalita del cerro, del carpino nero ed una decisa invasione delle faggete da parte del salicone (Salix caprea), accompagnato nei distretti più aridi dal prugnolo (Prunus spinosa), dal maggiociondolo (Laburnum anagyroides) e soprattutto dalla prodiga ginestra dei carbonai (Cytisus scoparius), pianta diffusissima nei suoli silicei lucani. Alle quote più elevate, al faggio ed all’abete si è sostituito in qualche caso il pino loricato, che gradualmente tenta di ampliare il suo areale approfittando del declino delle formazioni mesofile. In Calabria, all’abete ed al faggio si associa il frugale e vigoroso pino laricio (Pinus laricio), naturale successore delle faggeto/abetine degradate ed incendiate. Per questo motivo il pino laricio è più diffuso in Sila Grande che in Sila Piccola, dove invece il faggio e l’abete conservano estesi popolamenti, ricchi di piante secolari ed anche monumentali. Proprio in Sila Piccola era presente un gigantesco abete di di 2,54m di diametro, il più grande abete della sua specie, purtroppo incendiato da ignoti vandali nel 2001. Nella foresta del Gariglione e sul vicino Femminamorta vi sono alcuni tratti di bosco suggestivi, ricchi di piante colossali, alcune delle quali superano i 40m di altezza. Sulle vicine Serre, l’abete compare nuovamente associato al faggio ed all’ontano napoletano, ma la sopravvivenza e la continuità di questi nuclei è dovuta all’azione di conservazione operata nel corso dei secoli dai monaci dell’Abbazia di Serra San Bruno.
Nettamente diverso è il panorama forestale dell’Aspromonte, dove l’abete occupa cospicue estensioni boschive, sempre associato al faggio nei distretti più umidi ed al pino laricio in quelli più xerici. L’abete riesce persino a discendere nelle leccete dei versanti occidentali, in piena macchia mediterranea (600m), ma si tratta di occupazioni transitorie e dovute essenzialmente alla ceduazione delle sclerofille. Qui la conifera si associa al leccio (Quercus ilex), al corbezzolo (Arbutus unedo), alla fillirea (Phyllirea angustifolia), al mirto (Myrtus communis), erica (Erica arborea), ecc. Pochi chilometri più a sud e l’abete risale, sotto forma arbustiva e nel sottobosco, nelle faggete culminali del Montalto (1956m), giungendo a pochi metri dalla vetta. Questa stupefacente escursione altitudinale ed ecotonale, quasi unica nel suo genere, è dovuta alla ricchezza genetica che l’abete ha conservato sulle nostre montagne meridionali. Infatti, dalle montagne meridionali l’abete è ripartito nel postglaciale alla conquista delle regioni centrali europee, perdendo parte della sua variabilità genetica durante l’attraversamento dei diversi ecotoni. Per questo motivo, le popolazioni di abete dell’Europa centrale sono genericamente meno vitali di quelle dell’Europa meridionale ed è sempre per lo stesso motivo che gli abeti del sud Europa riescono a sopravvivere meglio in ambienti diversi rispetto ai popolamenti alpini ed oltralpe e ad assorbire meglio l’urto della concorrenza del faggio. Le caratteristiche genetiche proprie del nucleo “originario” appenninico terminano in corrispondenza dell’Appennino abruzzese, dove si hanno già ceppi genetici più simili a quelli alpini. Non a caso, la vitalità dell’abete decresce procedendo da sud verso nord.
Tuttavia, negli ultimi decenni, oltre agli effetti diretti dovuti all’impatto antropico, sotto forma di tagli e pascolo, le faggete e le abetine appenniniche stanno subendo gli effetti di condizioni climatiche non più idonee alla loro vegetazione. Reiterate fasi di pronunciata aridità primaverile ed estiva, accompagnata da elevata ventosità e nevosità invernale non adeguata, hanno dapprima provocato una generale moria di alberi vetusti ed isolati, poi la fase di decadenza si è allargata anche ai boschi adulti ed alla rinnovazione. E’ sufficiente osservare il colore delle faggete, sul finire dell’estate per rendersi conto che il faggio, ma anche l’abete, sono in condizioni di vita veramente precaria e basterebbe anche un solo intervento di taglio per interrompere il ciclo di rinnovazione che dura da millenni. Questo sta accadendo soprattutto nei versanti meridionali delle montagne calcaree e nei pendii che presentano gli strati inclinati a franapoggio, oppure laddove i suoli sono degradati ed inetti a garantire adeguata ritenzione idrica. Quindi, questo quadro climatico sta favorendo l’espansione delle cenosi forestali più xeriche e delle querce in genere a discapito delle cenosi più esigenti in fatto di umidità, atmosferica ed edafica. Certamente situazioni contingentali già verificatesi in passato, ma attualmente con feedback più incisivo a causa del progressivo degrado degli ecosistemi forestali, che vedono nella rarefazione dell’abete bianco un effetto di pronta determinazione.
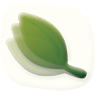




















Articolo davvero bello, specialmente la descrizione delle abetine meridionali ! Mi piacerebbe leggere sui popolamenti storici del Gran Sasso, anche in zona orientale…quindi suoli calcarei.
Arriverà anche quello.
ciao e grazie !
Sempre affascinanti le notizie che riguardano la storia delle nostre foreste.
Aspetto altri articoli!
Saluti
Fabrizio Di Meo
grazie !
Questo blog è affascinante e coinvolgente; complimenti!
Un saluto.
Nadia
Ottimo articolo, letto tutto d’un fiato. Un vero piacere
Grazie !
Articoli belli e profondi. Grazie Ha scritto qualcosa su eventuali presenze passate o attuali sulla catena del Partenio? E visto che l’abete prospera sui suoli argillosi non si potrebbe riforestare con esso tutta la fascia montana argillosa che va dal molise alla Lucania?
grazie per i complimenti. Per quanto ne so, sul Partenio l’abete era ancora diffuso nel XVIII secolo, ma potrei sbagliarmi. L’idea di rimboschire tutta la fascia argillosa appenninica molisana e lucana è una buona idea la quale, purtroppo, si scontra con i diritti della proprietà privata. Purtroppo, uno dei grossi problemi della montagna italiana (e non solo di quella) è l’estrema frammentazione della proprietà terriera. Tuttavia, vista l’attuale grave crisi economica verso cui ci stiamo velocemente avviando, chissà che si torni ad occupare una parte dei futuri disoccupati in opere di miglioramento del territorio. Staremo a vedere. Saluti
La ringrazio della risposta. Mi scusi ma solo ora me ne sono accorto. Ancora grazie e buone cose.
Molto interessante, tra l’altro ho capito finalmente come mai molte montagne dell’appennino siano così spoglie . Bel lavoro, come hai reperito tutte queste informazioni?
Grazie il per il commento. Le informazioni sono il risultato di anni di studi e di vita di “topo di biblioteca”. Un saluto
Grazie per l articolo, molto istruttivo. Volevo chiederle se per caso esistono masters dendrocronologici per le abetaie del sud Italia (Sila, Aspromonte) che permettano una datazione dei violini antichi napoletani del 1700.
Volevo chiedere anche se, secondo lei, i master alpini per l abete possono essere utilizzati per una datazione del legno della Sila, da cui i liutai napoletani attingevano il legno per i loro strumenti. Grazie
ciao, scusa per il ritardo. Di esami dendrocronologici ne sono stati fatti abbastanza, sia sulle Alpi che sull’Appennino. Tuttavia, non sono in grado di risponderti se questi siano poi stati applicati alla datazione degli strumenti musicali. Con le dovute differenze, si, gli abeti alpini sono correlabili a quelli appenninici. Ti suggerisco di cercare lavori in merito sul portale academia.edu e su researchgate
Articolo ben fatto, che esemplifica in modo chiaro le problematiche legate all’attuale gestione forestale appenninica.
Volevo chiederti se hai qualche dato sulla parte di popolazione che vive nell’appennino Emiliano – Romagnolo (comprendendo quindi il Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano).
Grazie,
Giacomo
ciao, scusa il ritardo.
Per l’Appennino settentrionale vale quanto detto a proposito dei monti della Laga. Inoltre, praticamente tutto il crinale tosco-emiliano-romagnolo, soprattutto sul lato Emiliano e romagnolo, è stato oggetto di tagli devastanti dopo l’unità d’Italia. A riguardo ci sono numerose immagini di repertorio di fine Ottocento nelle quali si vedono boschi ridotti al lumicino. Se conosci bene la zona, pensa ai faggioni rimasti attorno il Lago della Ninfa, sopra Sestola. Sono i resti di floride faggete atterrate verso il 1860. Non conosco l’anno preciso, ma ho delle immagini che li ritraggono una 40na di anni dopo che conferma tale ipotesi. Tale aspetto è comune a decine e decine di altre località appenniniche settentrionali, eccezion fatta per Sasso Fratino, che riuscì a superare indenne la crisi di fine Ottocento, ma non la prima guerra mondiale, quando fu interessato da un taglio per la produzione di carbone vegetale.
Fammi sapere se ti servono altre info.
un saluto